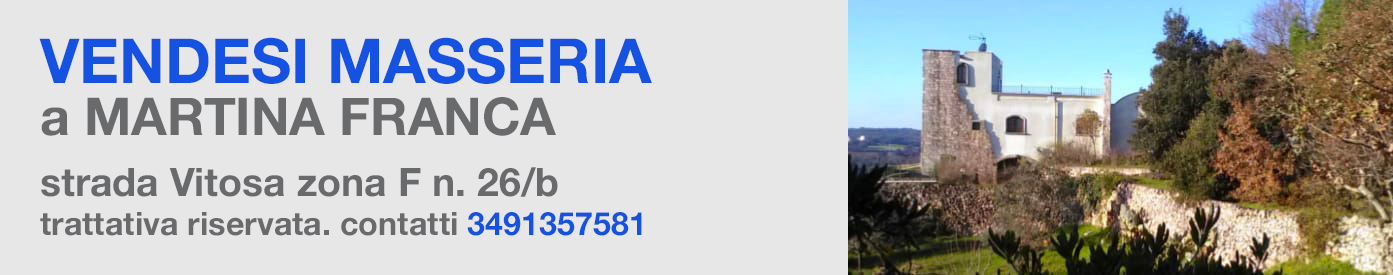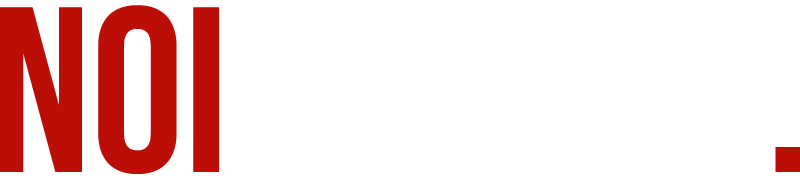Di Franco Presicci:
La neve del ’56 l’ho vista in foto. Non so come la mia vicina di trullo fosse riuscita a
scattarla, considerando che quella panna montava di minuto in minuto fino a
minacciare di fagocitare i trulli. Bisognava aprire un varco per poter percorrere quel
centinaio di metri da via Mottola alle case incappucciate. Ma che fatica. La neve è
bella: tra l’atro regala un abito da sposa a città e campagne. Ricordo la neve caduta
quando avevo 11 o 12 anni, sempre a Martina, ed ero ospite in casa dello zio
canonico, in via Marangi, dove dal balcone si poteva ammirare la Valle d’Itria. “Non
uscite, la neve cade a fiocchi e da terra si solleva parecchio”, ci consigliò don
Martino Calianno, mentre lui si preparava per andare a dir Messa non so più se alla
Basilica o nella chiesetta vicina.
La neve mi piace. Vederla in una scena invernale di Courbet mi emoziona. E mi
emozionava la vista dei fiocchi che imbiancavano le vie Nuova e Alfieri, nel centro
storico di Martina, creando poesia. Allora ero già grande, eppure non mi staccavo
dai vetri della finestra Con il passare degli anni ho assistito ad altre nevicate, non
paragonabili a quella del ’56. E, ogni tanto, guardo le immagini delle falde che
cadevano sull’ombrello del vecchietto che si avventurava nel vicolo.
Anche per questo mio amore per la neve ho accolto volentieri il libro della
scrittrice Maria Carmela Ricci, “Quella nevicata del 56 in valle d’Itria“, Giacobelli
editore. L’ho letto subito, con interesse, curiosità, piacere, e andando avanti mi
appariva sempre più bello, tra l’altro scritto con stile agile, scorrevole. Mi disturbava
il suono del campanello della porta, che mi costringeva a interrompere la lettura.
Sono pagine ricche di preziosità, che prendono il lettore e lo accompagnano in un
mondo ormai perduto, quello della civiltà contadina, con nonni, figli e nipoti,
costretti a stare in casa anche perché la neve ha quasi sbarrato le porte. L’autrice
dialoga con Nina, che all’epoca in cui si svolgevano i fatti aveva cinque anni e lo fa
con grazia, facendo rivivere in modo icastico una realtà lontana, ritmata dalla fatica,
dalla miseria dalle preghiere, dagli scherzi anche, quando la gente si scaldava, nelle
giornate rigide, con il braciere o con il camino acceso sotto il paiolo appeso alla
camastra.
La scrittrice non trascura nulla: descrive, oltre ai personaggi, tutte le parti della
casa: oncappucciata il palmento, la stalla, il fienile, e poi la scuola rurale…, attenta ai
particolari. “Il lunedì mattina Mimino andò nella stalla a governare Rondinella, la
‘docile cavalla storna’” della famiglia di tatà Martino e di Comasia, che baciava i figli
solo quando dormivano perché non crescessero deboli e impreparati ad affrontare
gli ostacoli della vita e nel timore che a manifestare affettuosità si potesse perdere
l’autorità. Improvvisante dalla stalla arrivarono gli urli di Mimino: la coda di
Rondinella è tutta intrecciata. “E’ la “jurie”, il folletto. Evidentemente Mimino era
rimasto turbato dai discorsi fatti la sera prima. A zio Giovanni, quel birbante,
intrecciava le criniere, a Comasia, quando partorì Mimino, lo spostava dal letto alla
culla e dalla culla al letto. Giocava, si divertiva, faceva dispetti. Ma il folletto era
stato inscenato da Ciccillo, per spasso. Erano due i mitici “giocherelloni”: l’altro era
“’u munacìedde” (lo scrivo alla maniera del dialetto tarantino).
Maria Carmela Ricci, come accennato, accompagna il lettore in una vista agli
ambienti: Dalla cucina si accedeva alla rimessa, che comunicava con la stalla e aveva
un’uscita esterna. In essa erano allocati: “u trajine”, “a sciarrette”, tre ”bacaclitte”.
In alto in una nicchia profonda, chiusa da uno sportello ligneo, erano sistemati gli
attrezzi pericolosi che venivano utilizzati per il lavoro nei campi o nei vigneti;
“ronghe”, “rungedde”, “rucegghione”, “asce”, falce, “cugnète”, nomi tradotti tutti
rigorosamente in italiano, e descritti così bene, che sembra di vederli schierati su
una mensola e di prenderli in mano, mentre Carmela si prepara a infornare il pane o
cucina fave con la verdura. E anche qui l’autrice snocciola i tempi di lavorazione, i
modi di fare l’alimento, la cura.
“Quella nevicata del ’56 in Valle d’Itria” è ricco di episodi. “Come ogni mattina gli
uccelli vennero a posarsi sula neve fresca per beccare le briciole di pane che Nina
lasciava loro” Tatà Martino disse che se non ci fosse la neve sarebbe andato a caccia.
L’ultima volta aveva fulminato “turde” e “frangeddere” (tordi e fringuelli). Tutti i
contadini avevano un fucile, con regolare permesso.
Piacevole l’uso del dialetto martinese che l’autrice fa citando attrezzi, utensili,
luoghi. Non per niente fa parte dell’Accademia d’a Cutezze, associazione che si
propone di salvaguardare e tramandare alle nuove generazioni la parlata dei
martinesi e le tradizioni locali; ed è attiva insieme ad altri scrittori, poeti, pittori in
vernacolo al Salotto Culturale di Palazzo Recupero, nella splendida dei trulli. Tra
l’altro il libro è molto bene illustrato con “capasonere”, vendemmia, catena del
focolare con caldaia (camastre p’a callère), capocolli appesi per l’asciugatura, un
calesse che lascia tracce sulla neve…, foto inizio del 900 del fotografo Eugenio
Messia. Insomma in questo libro c’è anche da vedere, oltre che da leggere.
L’indomani mattina i maschi, dopo aver fatto colazione con pane e pomodoro ed
essersi infagottati spalarono la neve in direzione del trullo-scuola. Occorreva
naturalmente crearsi un passaggio per procurarsi cibo e legna. Non si poteva
rimanere assediati dalla neve per molto tempo. La neve è bello vederla quando
scende rendendo candido il paesaggio: ma poi? Poi bisogna spalarla.
Più andavo avanti nella lettura e più queste pagine mi attraevano. Sono
innamorato di quel mondo, dei suoi usi e dei suoi costumi, dei modi di vivere dei
contadini, delle cucine monacali, dei forni, dell’ulivo, del fico, della quercia. Mi
colpiscono i lavoratori della terra, i vignaioli; adoro Martina con la sua campagna
imperlata di viti… E la trovo qui, scolpita da una scrittrice di talento, che fa rivivere
quelle giornate del’56 immerse nella neve, candida coperta, panna che monta nelle
strade, nei vicoli, sui tetti delle case, sulle altane, sui campanili, creando
un’atmosfera da favola.
La neve è poesia: “Il cielo è basso, le nuvole a mezz’aria/ un fiocco di neve
vagabondo/ fra scavalcare una tettoia o una viottola/ non sa decidersi” (E. Dickinso).
La neve ispira gli artisti della tavolozza. La neve inebria, mi commuove, anche
quando viene giù sottile, come moscerini che danzano. Questo libro tornerò a
leggerlo.
Laureata in Scienze Biologiche all’università di Perugia, Maria Carmela ha
insegnato anche matematica; e oggi in pensione coltiva di più le sue passioni di
sempre: poesia, narrativa e pittura. Faccio queste considerazioni e osservo ancora le
foto del libro. Ecco un contadino che pota le viti con il ronciglione, e un altro che con
la zappa smuove le zolle, entrambi colti dall’obiettivo di Benvenuto Messia. In altre
pagine dipinti di Maria Carmela: una casa a cono di gelato e un ulivo saraceno,
quindi poesie dell’autrice.
Rientro nel testo: “Tatà Martino fece uscire dalla stalla la cavalla, la bardò con i
finimenti, l’attaccò al calesse e con i figli maschi, partì per una ricognizione nei vari
vigneti di sua proprietà”. La neve aveva smesso di cadere.
Il libro si apre con una prefazione del professor Francesco Lenoci, docente alla
Cattolica di Milano, e con una postfazione di Teresa Gentile. “L’altro protagonista del
libro – dice il docente – è il dialetto martinese, la parlata dei genitori di Maria
Carmela Ricci… La nostra priorità è di non far scomparire la parlata dei nostri avi.
Perciò reputo che sia importante lasciarne tracce scritte…”. E segue con la memoria
delle tradizioni: i genitori gli hanno insegnato di non mettere il pane a pancia in giù;
non buttare mai il pane: voleva dire sputare alla miseria; il pane non deve essere
sprecato né maltrattato; bisogna portare il pane alla bocca mai con la mano sinistra,
bensì con la destra, la mano dell’angelo; ciascuna fetta di pace caduta dalla tavola
occorre recuperarla e baciata in segno di devozione; il pane inzuppato nel latte deve
essere sminuzzato con le mani, mai con il coltello….Anche la mamma faceva il pane
in casa”. Tornando al dialetto, si dice convinto che se si perdesse “scomparirebbe
una bagaglio di saggezza antica”. Lenoci adora il dialetto.
Nella postafazione Teresa Gentile, presidente del Salotto Culturale di Palazzo
Recupero, scrive che “la professoressa Maria Carmela Ricci, autrice del romanzo
‘Quella nevicata del ’56 in Valle d’Itria’ rivela nella sua scrittura fluida una cultura
classica ben sedimentata e una non comune sensibilità”. Tutto giusto. Io, finito di
leggere il libro, sono andato mentalmente indietro nel tempo, rispolverando ricordi.
Devo confessare che Maria Carmela Ricci, con il suo racconto cesellato, ha anche
arricchito il mio bagaglio.
Franco Presicci
“Quella neve del ‘56” di Maria Carmela Ricci
IL MANTO BIANCO SEMBRAVA
VOLESSE INGOIARE I TRULLI
In queste pagine, scritte con stile
scorrevole, si ritrova un mondo
fatto di sacrifici e fatiche. Luoghi,
persone, circostanze sono disegnate
con dovizia di particolari. Credenze
ormai sopite vengono raccontate
con abilità e cuore dalla bella penna
della scrittrice.